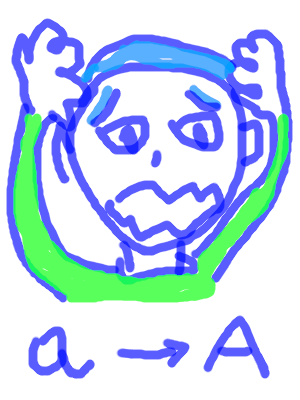
Per gioco, un mio collega di lavoro — che mi conosceva da poco — in mia presenza chiese a un altro collega, che invece mi conosceva da molto più tempo, di enunciare un mio pregio e un mio difetto. Il difetto gli venne subito in mente: sono restio al cambiamento. Per il pregio dovette riflettere qualche secondo, poi disse che mi adatto sempre. Suscitando così le grasse risate dei presenti.
Come accade per quegli episodi la cui portata, sia emotiva che simbolica, viene sul momento quasi trascurata, dopo qualche giorno quell’apparente contraddizione sul mio conto mi tornò in mente. Accese una lampadina e mi spinse a formulare una riflessione — certo non definitiva — sul tema del cambiamento in contesto aziendale e su un sottile equivoco in cui, di tanto in tanto, si inciampa: credere che la resistenza al cambiamento sia uno dei possibili tratti caratteristici di un lavoratore.
Escludo subito dal mio ragionamento i casi estremi: quei soggetti, più unici che rari, talmente insofferenti al cambiamento che non sostituirebbero nemmeno lo spazzolino da denti logoro all’inverosimile. Queste persone rappresentano casi patologici e, come tali, vanno trattati da professionisti della salute mentale.
Escludo anche la possibilità di giudizio basato sulle prime reazioni che seguono la notizia del cambiamento, perché non sono mai indicative né definitive. C’è chi manifesta da subito entusiasmo — spesso alimentato da grandi aspettative — salvo poi ricredersi; chi mostra indifferenza ma più tardi comprende di aver sottovalutato la portata della novità; chi ostenta serenità forzata per non turbare se stesso e gli altri colleghi e avere il tempo di maturare un’idea più solida; chi si mostra sereno perché, in malafede, ha intuito da subito che può sfruttare la circostanza per proprio tornaconto — naturalmente a scapito dell’azienda o di altri colleghi. C’è anche chi manifesta apertamente perplessità, come fanno le persone oneste e trasparenti, o chi si lamenta come i “bastian contrari”: entrambe categorie perlopiù innocue, che in fondo sperano solo che qualcuno le aiuti a ricredersi, perché non vogliono stare male.
Tutto ciò per dire che, sebbene la categoria di quelli “dal disappunto facile” sia la più malvista, non ritengo affatto che questa attitudine sia correlata con la reale capacità di affrontare un cambiamento.
Ciò premesso, azzardo la tesi che non esistano lavoratori realmente restii al cambiamento: possono solo sembrarlo o, nei casi peggiori, diventarlo — anche temporaneamente — a causa del modo in cui i loro superiori, se inadeguati al ruolo, gestiscono il cambiamento stesso. Sono questi ultimi, secondo me, l’unica categoria di lavoratori incapaci di far fronte al cambiamento.
Prima di argomentare la mia tesi, voglio sgomberare il campo da una tipologia di cambiamenti che consente a chi dirige di mettere, con frettolosa facilità, le mani avanti: i cambiamenti esogeni. Quelli, cioè, che provengono dall’esterno dell’azienda e sono dettati, in massima parte, da eventi naturali, da entità sovra-aziendali (come le associazioni di categoria) o da organi politici o giudiziari. In questi casi, si dice, “non c’è nulla da fare”. Ma davvero è così? Davvero, ad esempio, il legislatore indica sempre con dovizia di dettaglio non solo che cosa fare di nuovo rispetto a prima, ma anche come farlo?
Mettiamo che una legge preveda un nuovo modulo da compilare a fronte di una determinata circostanza. Si potrebbe pensare che non resti molto altro da fare se non rassegnarsi a seguire le istruzioni e compilarlo. Se il lavoratore ha ritrosie, quindi, dovrebbe prendersela con i politici che ha votato.
Ecco, non è esattamente così. Spesso esistono molti modi di compilare un modulo. Uno dei peggiori è farlo manualmente, alternandolo ad altre attività e senza verificarne il contenuto finale. Uno dei migliori è farlo digitalmente, con un software adeguato che acquisisca in automatico — dalle banche dati pertinenti — l’intero contenuto da inserire, compilando poi tutti i moduli a catena di montaggio. In questo modo si riducono al minimo gli errori e, di conseguenza, la necessità di controlli (che possono limitarsi a campioni sporadici).
Anche in questo caso, però, le mani avanti e le frasi fatte non mancano: “l’ottimo è nemico del buono”, “non abbiamo le risorse per creare questo sistema, intanto facciamo tutto a mano” e così via. Ma chi ha detto che si debba ottenere subito l’optimum? Meglio fermarsi un attimo, ragionare, organizzarsi in base alle risorse disponibili e, insieme alla squadra, individuare la via di mezzo più adatta come punto di partenza. Poi pianificare successivi miglioramenti.
Invito il lettore a trovare un qualsiasi controesempio che mi smentisca. Non ne troverà nessuno, per un fatto logico: anche di fronte a vincoli assoluti, rimane sempre almeno un margine di scelta — nel tempo, nel modo o nel significato della risposta al cambiamento — perché questa va di pari passo con le possibilità e le capacità degli esseri umani stessi. Se un giorno gli esseri umani non avranno più capacità e possibilità molteplici ma solo singole, probabilmente si estingueranno e basta.
Eliminate anche le giustificazioni più semplicistiche, arriviamo ai veri problemi legati al cambiamento. Questi, in genere, si verificano quando si prendono decisioni poco felici ai piani alti dell’azienda e/o quando c’è un totale scollamento con i livelli operativi e/o inerzia dei responsabili a qualsiasi grado gerarchico e/o scarsa trasparenza generale.
Supponiamo che i vertici prendano una decisione alla quale consegue un cambiamento. Capita che tali decisioni non appaiano sempre le migliori possibili a chi le subisce. In questi casi esistono vari modi per scongiurare la resistenza al cambiamento: i vertici possono argomentare in modo ampio e strutturato le motivazioni, rivelando quanti più retroscena possibile (entro i limiti delle informazioni riservate). Così, quando una decisione apparentemente assurda o ingiustificabile si rivela in realtà buona o ottima, gli strati più bassi della gerarchia possono convincersene e collaborare volentieri.
Se invece la decisione era obiettivamente sbagliata, non servirà essere chiari e trasparenti per ottenere l’appoggio morale dei piani bassi. Qui subentra il ruolo strategico dei responsabili gerarchici intermedi, che possono almeno in parte rimediare alla decisione errata. Intanto dovrebbero, con onestà intellettuale e sempre con il dovuto rispetto, ammettere che i piani alti potrebbero aver sbagliato. Poi, pur ricordando che la decisione va comunque accettata, dovrebbero analizzare insieme ai collaboratori la situazione per capire quali margini esistano nella gestione del cambiamento e come ottimizzarne l’impatto. Infine, dovrebbero farsi carico delle proposte — proprie e dei collaboratori — e indirizzarle ai vertici, con i giusti modi e tempi, affinché si possa correggere il tiro, in tutto o in parte, per il bene dell’azienda.
Se questo processo non si attua almeno in parte, è facile che un lavoratore appaia restio al cambiamento, anche se nella maggioranza dei casi, poco dopo, si adatta con diligenza (o, ove possibile, cambia azienda). Alla base di tutto questo ragionamento c’è sempre il lavoro di squadra e la partecipazione attiva e propositiva di tutti, entro il proprio ruolo.
I responsabili devono gestire la “malavoglia” anche nel post-cambiamento. Può accadere che un cambiamento venga accolto da subito con favore a ogni livello, oppure con apparente indifferenza, per prudente attendismo. E non è affatto detto che, in un secondo momento — una volta realizzato appieno il cambiamento — non emergano insofferenza e contrarietà.
Anche in questo caso occorre intervenire, benché a volte sia più difficile: quando solo un gruppo ristretto, o addirittura una singola persona, non ha digerito un cambiamento che a tutti continua a sembrare positivo, è forte la tentazione di reagire con indifferenza o di isolare il soggetto, respingendo ciò che avrebbe da dire. Ci sono due possibilità. Se le obiezioni sono valide, anche solo in parte, ignorarle è un’occasione persa: è semplice evitare la fatica di gestire un problema che non si era notato prima e che ha rilevato una sola persona, facilmente silenziabile, a differenza delle masse. Ma non è detto che, prima o poi, anche altri non inizino ad accorgersi del problema. Quindi, mai perdere l’occasione di correre ai ripari se qualcuno intuisce, anche a posteriori, che qualcosa non va.
Il secondo caso è quello in cui le obiezioni sono infondate. A quel punto basta mettersi in ascolto di chi manifesta disagio, con attenzione: aiutarlo a risolvere dubbi e perplessità, dargli strumenti per una migliore comprensione e una più efficace operatività — in poche parole, metterlo nelle condizioni di affrontare il cambiamento che, a differenza di altri, lo ha messo in difficoltà. Se l’azione di supporto non funziona, occorre chiedersi se non si sia stati in grado di aiutarlo — e, in tal caso, cercare aiuto per farlo meglio — oppure se il cambiamento abbia toccato i limiti oggettivi di quella persona. In quest’ultimo caso, può essere opportuno proporle una mansione diversa, che valorizzi altre sue capacità.
In conclusione, al netto dei casi patologici, la resistenza al cambiamento non è mai un’attitudine del lavoratore, ma un segnale la cui insorgenza deve essere prevenuta il più possibile e, se si manifesta, gestita al meglio. Anche perché talvolta rappresenta un’opportunità persino salvifica. Il tutto, quasi sempre, a costo soltanto di un minimo sforzo di buona volontà da parte di chi è chiamato a dirigere.